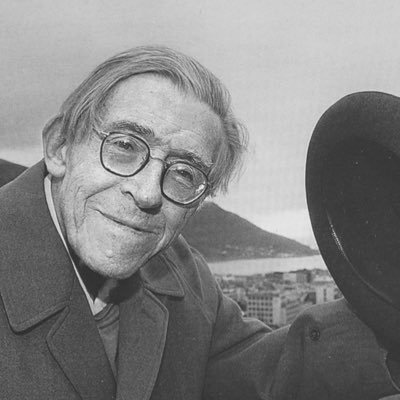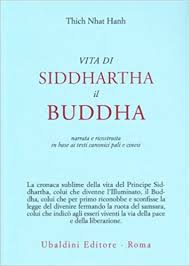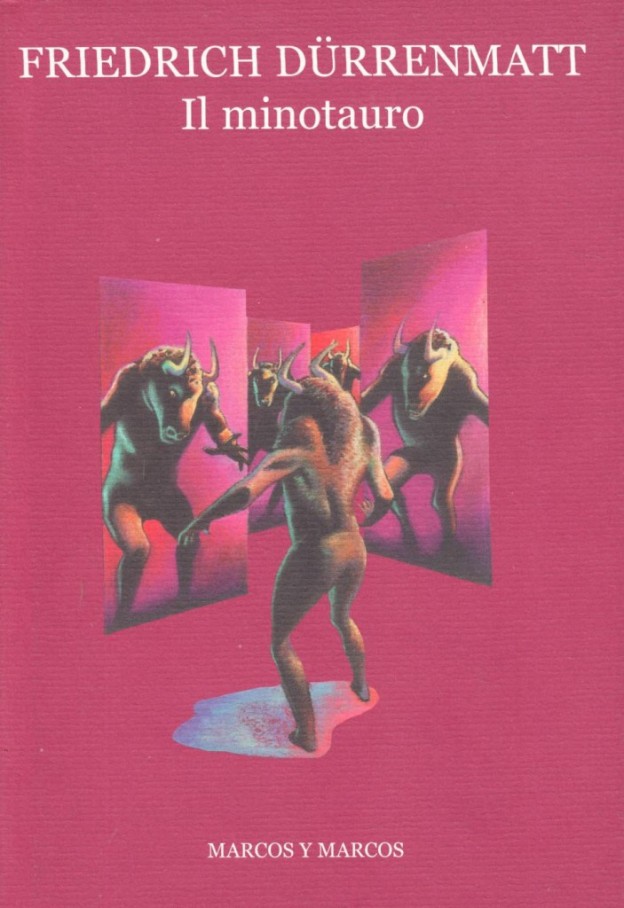Amore e rivoluzione. Cosa hanno in comune?
Ad un primo sguardo potremmo dire che un momento rivoluzionario, al pari dell’amore, rappresenta una rottura col mondo, col regolare corso degli eventi, un evento che solleva la polvere sedimentata che impedisce al nuovo di emergere. Ma cerchiamo di andare più a fondo. Ciò che implica una sollevazione popolare è la creazione di un Noi a partire da minuscole separate individualità. Il punto non è l’amore. Cosa è allora? (pausa ad effetto, rullo di tamburi)
La solidarietà. Certo, ogni atto di solidarietà contiene amore, è una specie di amore, ma distillato, più grande, amore all’ennesima potenza. Per sviluppare la solidarietà, abbandonare quella perniciosa abitudine che tutti abbiamo a soddisfare solo i propri interessi, è necessario l’impegno e l’autodisciplina. Si tratta di energia: disperdere in vani piaceri ciò che invece potrebbe essere convogliato nella lotta rivoluzionaria. Va detto però che secondo alcune correnti di pensiero è il desiderio stesso ad essere rivoluzionario, come si può osservare negli stati totalitari. Il desiderio, sia chiaro, inteso come spinta e non come baccanale. Per esempio Deleuze:
“Checchè ne pensino certi rivoluzionari, il desiderio è nella sua essenza rivoluzionario – il desiderio, non la festa – e nessuna società può sopportare una posizione di desiderio vero senza che le sue strutture di sfruttamento, di asservimento, di gerarchia vengano compromesse”
Può essere interessante vedere cosa ne pensava al riguardo quel grande rivoluzionario del novecento che risponde al nome di Vladimir Il’ič Ul’janov, conosciuto come Lenin. In una lettera egli scrive:
“Nella vita sessuale si manifesta non solo ciò che noi deriviamo dalla natura ma anche il grado di cultura raggiunto, si tratti di cose elevate o inferiori. Certo, la sete deve essere tolta. Ma un uomo normale, in condizioni ugualmente normali, si butterà forse a terra nella strada per bere in una pozzanghera di acqua sporca?”
Lenin si pone su un pericoloso crinale, sospeso fra moralismo e necessità rivoluzionaria, cercando di conciliare libertà e autodisciplina. Il socialismo doveva certamente promuovere la gioia di vivere e la potenza della vita, e un amore vissuto nel senso pieno della parola era cosa bella ed utile, tuttavia l’ipertrofia degli incontri sessuali, il cieco piacere fine a sè stesso, era giudicato inutile, se non pericoloso a fini rivoluzionari. Il riSchio sottointeso era perdersi nel proprio piccolo sè invece di espandersi e creare un noi su cui fondare una società più solidale e giusta.
E che dire allora del tormento provato da Che Guevara durante tutta la vita, dovendo scegliere fra l’amore per la compagna e i figli e la lotta per l’emancipazione dell’uomo. In questa lettera all’amata, le parole emergono come ferite:
“Amami, appasionatamente, ma capiscimi: il mio destino è segnato, niente mi fermerà fino alla morte. E non piangerti addosso; affronta con decisione la vita ed escine vincitrice. E così potremmo ancora fare qualche tratto di strada assieme. Quel che mi porto dentro non è una sterile sete d’avventura. Ciò che comporta io l’ho sempre saputo; tu avresti potuto immaginarlo”.
Ciò che ci insegnano queste esperienze, limitate e non esaustive, è che forse ciò che un uomo dedito al cambiamento deve fare è rendere puro il suo amore. La pretesa al possesso esclusivo di un altro essere umano non è il vero amore, anzi è l’esatto contrario. Ciò che, anche nel mondo odierno, si è reso necessario è un movimento di allargamento: uscire dalla ricerca del piacere, dalle proprie paure, e abbracciare ogni persona con l’amore. Un movimento d’unione e non d’esclusione è possibile: la propria amata e tutto il resto. Questa è la forza rivoluzionaria del vero amore.